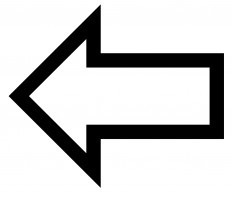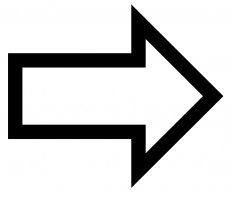La Frequenza dei ricordi
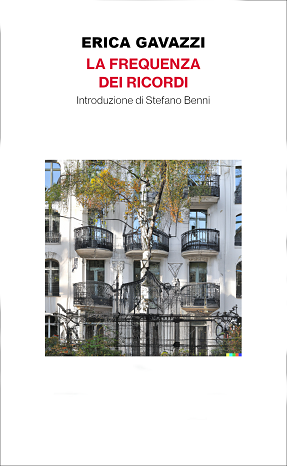
Tutto ebbe inizio un sabato pomeriggio.
Le parole mi frullavano in testa e non davano segno di volersi placare.
Mi sdraiai e chiusi gli occhi.
Ma chi avrebbe dormito?
Adesso che avrei avuto tutto il tempo per farlo, me ne mancava la voglia.
L’adrenalina arriva sempre quando non serve.
Il nostro cervello è strano: ti fa vedere ciò che vuole.
Accadde così.
Stavo correndo con la mia bicicletta e il freddo era penetrante. Qui, il gelo non aspetta il 21 dicembre. Cala all'improvviso e avvolge tutto nella sua brina brumosa che si attacca alle ossa e non ti abbandona più fino a Beltane, quando i falò purificano l'aria e bruciano ogni turpitudine.
Checché se ne dica, ognuno rimane invischiato nelle proprie prigioni per sempre.
Nessuno ti libera.
Un giorno, ti gettano in fondo al mare con una palla al piede e un cappio al collo e rimangono sul pelo dell’acqua a vedere come te la cavi. Se te la cavi.
Io me la sono cavata, ma dentro di me è rimasto per sempre l'inverno.
2.
All'incrocio tra Unter den Linden e Friedrichstrasse, si ergeva un maestoso palazzo in stile romanico, attorniato da due betulle innamorate e una grossa quercia accoccolata su una collinetta di sassi. Un edificio elegante. Non si poteva dire lo stesso del portone in metallo arrugginito e con gli angoli pieni di ragnatele.
Le ragnatele mi piacciono molto. Rappresentano la realtà senza spiegarla, così come fanno i simboli: rendono manifesta una relazione, trasportando la mente in un mondo altro, in un ricordo o in un’emozione.
Il tempo passa e non ritorna.
Forse è proprio quel ritorno che cercavo. Inconsciamente, vivevo una separazione tra ciò che desideravo nel profondo e ciò di cui in realtà avevo bisogno.
Ma non è forse la condizione normale dell’essere umano vivere di aspettative, perdendo la possibilità di vivere la realtà? Non è forse umano pensare sempre al domani, dimenticando che il domani è l’oggi che abbiamo costruito con cura e dovizia e vissuto fino al midollo?
Io, di liquidi ne avevo ingoiati a sufficienza. E del midollo, non m’importava.
Si vive indifferenti ai bisogni. Si impara a essere opportunisti. Perché non solo in politica, si fa strada il trasformista. I freddi calcoli fanno parte della natura del dolore mal sopportato e mai accettato.
Ci saranno voluti decenni per costruire questo palazzo con quei balconi dal parapetto bianco risaltato da fregi floreali, ingrigiti dalle polveri sottili che inquinano l’aria e soffocano.
Le lavorazioni in ferro battuto sorreggevano una grossa vetrata policroma che rifrangeva la luce del sole, facendo penetrare i suoi raggi nel piccolo buco creato da qualche picchio nella cavità del grosso tiglio che delimitava il confine di quell'edificio con quello successivo. Le serie sono infinite anche nella realtà.
Entrai nel portone e presi le scale. Salii un gradino alla volta, piano. Lentamente mi tornavano in mente immagini di momenti che non ricordavo di aver vissuto.
Sembrava di tornare indietro nel tempo. Un tempo lontano quando i tigli avevano ancora il profumo della gioia e dell'attesa, il profumo dello scambio allegro dei regali nel giorno di Natale.
Arrivai al secondo piano. Aprii la piccola porta bianca che separava le scale da uno stretto corridoio. Come la mia vita: mi stava stretta; e la pelle bianca pallida costretta in un pantalone di una taglia in meno si raggrinziva come quella sul volto di una vecchietta.
Non volevo accettare di dover convivere con una taglia che non mi apparteneva, seppur la minima vitale.
Si nasce con convinzioni sbagliate e si cresce cercando di sfuggire a queste idee.
L'odore di vecchio ritornò. Odio quell'odore. Chissà poi perché i vecchi emanano quell'intenso odore di muffa all'acqua di Colonia
Ho pianto molto.
Non ricordo neanche più per cosa.
Certamente era qualcosa d’importante, se mi sono ridotta così dal troppo pianto.
Mi ritrovai in una stanza bianca, tutta spoglia, fredda come l'acciaio sul quale era poggiata la bara di mia nonna in un caldo e assolato giorno d'agosto. Mi ritrovai sdraiata su un lettino cigolante, con gli occhi fissi al soffitto e un groviglio di pensieri che rumoreggiavano ed echeggiavano nella stanza vuota. Non li ricordo. Così come si raggomitolavano nella mia testa, si scioglievano fugacemente subito dopo essersi presentati.
Sentivo tutte le ossa dolere e i muscoli sembravano come intirizziti dal freddo. Paralizzati.
Non poteva essere stato freddo quello che provavo.
Il tepore del piumone che mi copriva donava sollievo alle ossa e il dolore sembrava evaporare.
Allora, che cos’era che mi schiacciava e appesantiva tutti i miei organi, rendendo le mie braccia dure come il piombo e le mie gambe freddi bastoni di legno?
Nella testa picchiava forte il cuore e, nella parte superiore del cranio, un bruciore intenso martellava la fontanella mai chiusa. Cuoceva la pelle come avviene con un’ustione: bruciava da sotto e crepitava da dentro. Unico indizio: un flebile ronzio pulsante e continuo. Fastidioso e implacabile.
Aprii gli occhi e fissai la finestra aperta davanti a me.
C’era aria di temporale.
Basta un piccolo segno per cambiare il senso di ogni cosa. Perché ero lì?
Qual era stato il mio punto fermo lungo la strada in divenire del tempo?
Le esperienze della vita partono da pensieri incartati e da desideri e sogni che per qualche strana ragione sono sfuggiti di mano. Aspettative raccolte ai margini di una strada affollata: inquinate da abitudini sbagliate e infettate dai condizionamenti altrui.
Che cosa dà al rotore la forza per creare corrente continua?
Quale scossa, quale input genera il movimento?
Avrei voluto girarmi.
Ma tutto in me tremava. Tutto intorno a me aveva preso a girare, come quando da piccola salivo sulla giostra di cavalli, aspettando con trepidazione che partisse. E partiva, ma sempre nel momento sbagliato: quando mi voltavo per salutare la mamma e non la vedevo più o quando mi cadeva dalle mani quella amata bambolina di pezza dal viso di plastica fosforescente e rimanevo ferma, inerme, sul cavallo con gli occhi sgranati a fissare la mia Lucetta che scorreva come un fiume sotto di me fino alla fine della corsa.
Ero stanca.
Sentii una voce. Mi stava chiamando.